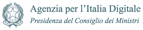Ti trovi in: Abruzzo Cultura > Visualizzazione Scheda
Ti trovi in: Abruzzo Cultura > Visualizzazione Scheda
San Sebastiano

Misure: 178 (a) (cm)
Datazione: sec. XV 1478 / 1478
Museo Nazionale d'Abruzzo - MUNdA
L'Aquila (AQ)
Silvestro di Giacomo da Sulmona detto Silvestro Aquilano 1450 ca./1504
Il Santo è rappresentato a tutto tondo, stante, il peso del corpo sostenuto dalla gamba sinistra; le braccia sono legate dietro, intorno al tronco dell'albero. Ha la testa sollevata, lo sguardo rivolto verso l'alto e la bocca dischiusa. La policromia originale è integralmente conservata.
Il San Sebastiano è una delle più note sculture rinascimentali d'Abruzzo. L'iscrizione lacunosa sulla base lo data al 1478. Il contratto del Dicembre di quell'anno, pubblicato dal Leosini (1848) che ne ha rinvenuto la trascrizione nei manoscritti dell'Agnifili nella Biblioteca Provinciale dell'Aquila (cfr. Chini, 1927), reca il nome dell'autore della scultura e dei committenti, l'abate del monastero di Santa Maria del Soccorso e Domenico Antonio Caprini d'Ariscula. Citata spesso dalla letteratura locale ed esposta alla Mostra del 1905, questa scultura è stata al centro della discussione sulla formazione di Silvestro di Giacomo. Il Rusconi (1906) vi ha riscontrato generici caratteri toscani; il Venturi (1908) ha considerato Silvestro un seguace di Antonio Rossellino e ha confrontato quest'opera con la scultura raffigurante San Sebastiano nella Collegiata di Empoli, del Rossellino (1457). Questi riferimenti sono stati ripresi dalla critica successiva (Serra, 1922; ID, 1929; Inventario, 1934). Il Balzano (1924) ha collegato il San Sebastiano ad un dipinto di scuola del Botticelli nella Pinacoteca Vaticana; il Mariani (1930) vi ha notato "evidenti ricordi" del Verrocchio e del Rossellino, seguito dal Chini (1954). La Mack Bongiorno (1942) ha esculso il rapporto con la scultura del Rossellino; i modi verrocchieschi di Silvestro e la conoscenza dell'opera di Desiderio da Settignano che riscontra nelle sculture di Silvestro la inducono a proporre un soggiorno dell'artista a Firenze tra il 1471 e il 1476. In particolare, il San Sebastiano si può collegare, per questa studiosa, al tipo popolare diffuso nell'Italia centrale, che sarebbe culminato alcuni anni più tardi nelle patetiche rffigurazioni del Perugino. Il Rotondi (1952) ha ritenuto, invece, l'influenza del Verrocchio mediata attraverso lo scultore Francesco di Simone Ferrucci, presso la cui bottega si sarebbe trattenuto lo scultore aquilano negli anni 1471-1476. Anche il Carli (1960) ha escluso il collegamento con il Rossellino e ha accostato Silvestro a Matteo Civitali, seguito dal Seymour (1966); il Moretti (1968) ha riscontrato nel San Sebastiano elementi verrocchieschi rielaborati nello spirito di modelli umbro-marchigiani.