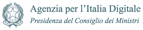Ti trovi in: Abruzzo Cultura > Visualizzazione Scheda
Ti trovi in: Abruzzo Cultura > Visualizzazione Scheda
Chiesa di Santa Maria Assunta

Come arrivare
La chiesa di Santa Maria Assunta, insieme all'Oratorio di San Pellegrino, faceva parte di un complesso monastico che affonda le sue radici nei primi secoli del Cristianesimo, tra III e IV secolo, quando sul luogo venne sepolto il corpo di un missionario laico, San Pellegrino, che a Bominaco subì il martirio morendo trafitto dalle lance. Alcuni secoli dopo, intorno all'VIII, su quella tomba venne edificata una prima chiesa che venne donata all'abbazia benedettina di Farfa, dalla quale si rese indipendente solo nel 1001. Di tutto il complesso oggi restano solo la Chiesa e l'Oratorio, due splendidi esempi dell'architettura romanica abruzzese. La data di costruzione della chiesa di Santa Maria Assunta non è definita ma possiamo sostenere con certezza che precede le due datazioni riportate sul pulpito, 1180, e sull'altare, 1223, e perciò va riferita al periodo tra la fine dell'XI e l'inizio del XII secolo. Il primo riferimento all'edificio religioso lo troviamo in un diploma del Chronicon farfense che conferma questa datazione. Il completamento e l'arricchimento della struttura primitiva avvenne nei secoli XII e XIII, al tempo della cosiddetta rinascenza bominacense. Lo stile adottato fu quello del romanico classico, pulito e chiaro nelle forme, tipico delle costruzioni monastiche medievali. La chiesa conserva ancora oggi la sua impronta originaria seppure all'interno ha subito una trasformazione in epoca barocca. La chiesa trova il suo riferimento nella struttura di San Liberatore a Majella di cui ricalca la pianta basilicale a tre navate e tre absidi, con una novità di rilievo nella sostituzione delle colonne al posto dei pilastri delle navate. La copertura dell'aula in origine era a tetto in legno; a questa si sovrappose poi la decorazione a volte barocche. Il presbiterio, cui si accede attraverso tre piccoli archi trionfali poggianti su pilastri a sezione cruciforme, si trova in posizione rialzata rispetto all'aula e presenta una copertura a tre volte a crociera con la campata centrale rinforzata da costoloni. La facciata rappresenta un unicum nel panorama architettonico abruzzese. E' una semplice parete di pietre a cortina di conci con terminazione cuspidata nella parte centrale ed orizzontale nelle ali laterali in corrispondenza delle navatelle. L'adozione della cuspide deriva dalle cattedrali pugliesi mentre la terminazione orizzontale diventerà prototipo dei prospetti squadrati delle chiese aquilane del '200 e '300. Sull'ala destra si inserisce un campanile a tre fornici. Sulla facciata si aprono un portale dalle forme semplici e pulite ed una grande monofora. La decorazione dell'archivolto e dell'architrave del portale ricorda quella dei portali di San Liberatore a Maiella e San Pietro ad Oratorium. E' costituita in prevalenza da un motivo a palmette a pannocchia che ricopre per intero il doppio giro dell'archivolto mentre sull'architrave si alterna ad un motivo di fiori stelliformi con una figura di leone in posizione centrale. La finestra con arco a tutto sesto è inquadrata da una cornice a rilevo sulla parete, sulla quale sporgono quattro leoni a mensola che tra le zampe stringono le prede. Le pareti laterali della chiesa non sono identiche; quella di sinistra, collegata anticamente con il monastero, risulta liscia e semplice, quella di destra si presenta lavorata e decorata. La linearità delle pareti è interrotta da due semplici portali e da strettissime feritoie che presentano, negli archivolti, motivi ornamentali vari. Il prospetto posteriore dell'edificio presenta una struttura a tre absidi, che rivelano forme di derivazione lombarda poi rivisitate alla luce del linguaggio del romanico abruzzese. Quella centrale, più alta delle laterali, è divisa in tre campate da semicolonne che, nella parte alta, si tramutano in pilastri e terminano in originali capitelli. Ogni campata ospita una feritoia con strombi e ricca decorazione esteriore, più alta quella centrale e di grande effetto decorativo quella di sinistra. Nove arcatelle definiscono in senso orizzontale l'abside centrale. L'abside di sinistra è ben conservata mentre quella di destra ha perso ogni decorazione. Tutte le tribune poggiano su un alto basamento ma la ripartizione in campate riguarda solo quella centrale. La chiesa contiene all'interno un complesso di eccezionale pregio artistico costituito dalle dodici colonne, dal pulpito e dal candelabro. Le colonne sono tutte disuguali nelle dimensioni, nella forma delle basi e nei capitelli. Costituite da blocchi monolitici, poggiano su basi attiche e culminano in bellissimi capitelli che si ispirano allo stile corinzio, in un discorso di sintesi della tradizione classica. Il motivo decorativo è di carattere vegetale con scarsa originalità creativa. Ad opera dell'abate Giovanni nella seconda metà del Duecento la chiesa si arricchisce di arredi che costituiscono vere opere d'arte. A lui si deve l'ambone che si trova sul lato sinistro della navata centrale e che fu realizzato nel 1180, come testimoniano le tre iscrizioni che corrono sul listello della cornice terminale e sull'architrave. E' formato da quattro colonnette, di cui tre cilindriche ed una scanalata a spirale terminanti in capitelli corinzi a fogliame d'acanto, che sorreggono altrettanti architravi. Particolarmente lavorato è il fregio dell'architrave che riproduce gli stessi motivi vegetali dei capitelli misti a figure animalesche, come l'agnello, il lupo o il leone e a scene di caccia e di vita quotidiana, che rinviano alla tradizione classica reinterpretata secondo i caratteri tipici della scultura abruzzese del tempo. Sul fregio poggiano, in funzione di delimitazione del piano, i davanzali rettangolari che si presentano divisi, per mezzo di un pilastrino, in due sezioni contenenti ciascuna un fiorone scolpito, elemento decorativo appartenente alla scuola di Valva. Eccezione fa il davanzale frontale che risulta diviso in tre scomparti, di cui il centrale, destinato a leggio, sporge con un semicilindro lavorato con un loggiato cieco. All'iniziativa dell'abate Giovanni si deve anche la cattedra abbaziale sulla quale egli si fece raffigurare con il baculo pastorale, simbolo dell'autonomia dell'abate dai vescovi valvensi. Un'epigrafe sul lato sinistro ne indica la cronologia dedicando l'opera a Gesù Cristo. Probabilmente realizzata dallo stesso scultore dell'ambone, la cattedra richiama lo stile dei troni vescovili pugliesi. Di qualche decennio successivo sono il ciborio e l'altare, datati al 1233, anno della consacrazione della chiesa. A favorirci in questa ricostruzione cronologica è l'iscrizione riportata sul bordo della mensa eucaristica. Il ciborio è stato ricostruito in seguito ai lavori di restauro del 1939-40. In quell'occasione furono ritrovate due colonne, l'architrave di sinistra ed alcune colonnine dei piani superiori che hanno consentito la ricostruzione di un ciborio di grande interesse ed originalità. Sul pannello frontale dell'altare è scolpito ad alto rilievo l'Agnello crocifero, motivo che si trova negli altari e portali aquilani del tempo. Nella zona presbiteriale, accanto al ciborio si trova un cero pasquale tra i più belli ed originali dell'intera regione. Un leoncino stiloforo sorregge una colonna tortile che, mimando un movimento avvolgente e morbido, culmina in un capitello elegante e delicato su cui poggia una corona di gusto bizantineggiante destinata ad ospitare il cero.